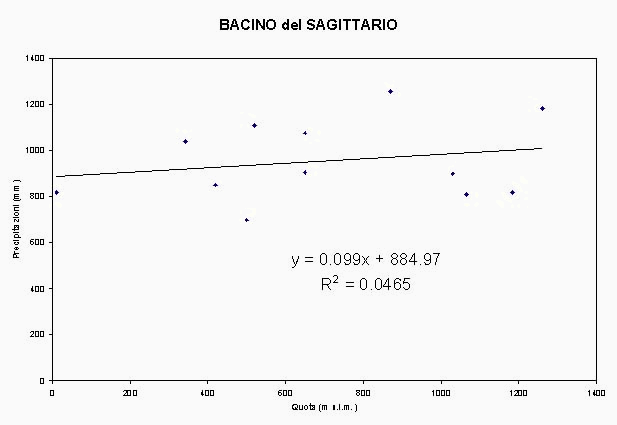Relazione a cura dell'Istituto Idrografico e Mareografico di Stato di Pescara
2002
direttore ing. Mario Russo
CARATTERISTICHE IDROLOGICHE DEL BACINO DEL FIUME PESCARA
Premessa: allo stato attuale la portata del fiume è diminuita rispetto alle quantità sottoriportate a causa di prelievi per l'irrigazione, acqua potabile e usi industriali.
Premessa: allo stato attuale la portata del fiume è diminuita rispetto alle quantità sottoriportate a causa di prelievi per l'irrigazione, acqua potabile e usi industriali.
Il Fiume Pescara, che sfocia in Adriatico in corrispondenza dell’omonima città, è alimentato, nel suo corso più alto, dai deflussi dagli Appennini Abruzzesi, che raggiungono le quote più elevate della catena.
Il corso d’acqua, che dalla gola di Popoli si dirige, con corso poco pendente, verso la costa Adriatica con direzione pressoché normale alla costa stessa, è alimentato, a monte della gola, dalla confluenza del Fiume Aterno, che proviene da Nord-Ovest, e del fiume Sagittario, che scorre da Sud-Est.
Tale conformazione, anomala per i corsi d’acqua appenninici con foce in Adriatico, deriva dalla corrispondente particolare conformazione della catena montuosa, che presenta due diversi spartiacque paralleli al mare, essendo il più prossimo alla linea costiera interrotto dalla profonda valle rocciosa di Popoli, determinata da una faglia che separa il monte Morrone dalle propaggini meridionali del massiccio del Gran Sasso.
Il primo spartiacque, orientale, è caratterizzato dalle quote più elevate che l’Appennino insulare raggiunge, col Monte Corno (Gran Sasso - 2814 m s.l.m.) e col Monte Amaro (Maiella - 2714 m s.l.m.)
Il secondo spartiacque, parallelo al primo, verso occidente, raggiunge quote meno elevate (M. Sirente - 2349 m s.l.m.), ma comunque ragguardevoli.
La valle tra le due catene è drenata, come indicato, dall’Aterno e dal Sagittario, che scorrono ambedue, con diversa morfologia d’alveo, verso la gola di Popoli.
La particolare conformazione del bacino si evidenzia bene nella carta tematica (tavola 1) nella quale sono anche indicate le ubicazioni delle stazioni di misura delle precipitazioni,

tavola. 1
 |
| Foto 1 |
La valle dell’Aterno
L’Aterno nasce dalla conca alluvionale di Montereale alla quota di circa 800-850 m s.l.m., ed è alimentato dai deflussi del massiccio che culmina nel Monte Civitella (1616 m s.l.m.), sul quale si localizza lo spartiacque che divide il bacino apparente dell’Aterno da quello del Vomano.
Sino all’abitato di Marana scorre da NE a SO in una valle angusta con fianchi costituiti da marne ed argille sabbiose.
Da quell’abitato piega a sinistra, con direzione da NO a SE. La valle, che si allarga gradualmente, ha fianco destro costituito ancora da argille sabbiose e marne, con varia agglomerazione, e fianco sinistro da calcari, sempre marnosi, ai quali si appoggiano numerosi conoidi di deiezione le cui basi costituiscono, in prevalenza, la sponda del corso d’acqua.
Dopo l’abitato dell’Aquila, pur con immutata direzione, la valle, che diventa più amena, presenta sui due fianchi prevalenza di calcari organogeni e di depositi vari, sempre d’origine calcarea.
A monte dell’abitato di Raiano la valle calcarea si restringe offrendo, per l’impervia sua configurazione, scorci paesaggistici di notevole interesse. Uscito dalla gola il corso d’acqua cambia ancora direzione, verso NE, e, dopo un tratto di alcuni chilometri, percorsi tra depositi alluvionali calcarei, confluisce, a monte dell’abitato di Popoli, col Fiume Sagittario.
La valle del Sagittario
Il corso d’acqua ha origine dal gruppo montuoso che culmina nel monte Godi (2011 m s.l.m.) e procede con direzione da SE a NO verso il Lago di sbarramento di Scanno, col nome di Fiume Tasso.
Dal lago di Scanno, che non ha emissario visibile, dopo un corso recondito, infiltrato nei depositi morenici calcarei che al lago hanno dato origine, riemerge col nome di Sagittario a monte dell’abitato di Anversa degli Abruzzi, alimentato da molteplici risorgive, talvolta direttamente rifluenti in alveo.
Da Anversa, e fino all’abitato di Bugnara, il Fiume procede con immutata direzione in una valle con fianchi acclivi, di notevole interesse paesaggistico; a valle dell’abitato di Sulmona, la sua direzione piega verso NO sino alla confluenza con l’Aterno, scorrendo in valle amena e con fianchi costituiti da antichi depositi alluvionali terrazzati.
La valle del Pescara
Dalla confluenza tra l’Aterno ed il Sagittario il corso d’acqua prende il nome di Pescara e giunge all’Adriatico con direzione costante, da SO a NE.
Subito a valle della confluenza il corso d’acqua, rimpinguato da molteplici e cospicue risorgive, si addentra nella gola tettonica di Popoli ove scorre per alcuni chilometri. Al suo termine la valle diventa amena anche perché costituita da depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi su base argillosa, e quindi facilmente erodibili, e quindi, con immutata configurazione, perviene sino al mare.
E’ interessante notare come la differente conformazione dei sottobacini del bacino trovi puntuale riscontro nella denominazione dei vari tratti del corso d’acqua che, dalla confluenza tra l’Aterno ed il Sagittario continua a chiamarsi Aterno-Sagittario sino alla confluenza delle sorgenti di Capo Pescara, e quindi all’ingresso nelle gole di Popoli, ove assume il nome di Pescara, quasi a rimarcare le differenze morfologiche che caratterizzano i diversi tronchi del corso d’acqua.
Dalla carta tematica della permeabilità superficiale dei suoli (tavola 1) ben si intende come i sottobacini dell’Aterno e del Sagittario siano decisamente più permeabili del sottobacino del Pescara e che, di conseguenza, una gran parte della pioggia che su di essi cade si infiltri nel sottosuolo per venire a luce più a valle ed in un tempo successivo.
Le portate di massima piena del Pescara alla foce dipendono essenzialmente dalle precipitazioni che avvengono a valle della gola di Popoli, ed in particolare, dalla zona di Caramanico e S. Eufemia, ove tali precipitazioni sono più intense.
gole di Popoli
IL BACINO DEL FIUME PESCARA
Il fiume Pescara ha il bacino imbrifero più esteso tra quelli dell’Italia insulare con foce in Adriatico, con una superficie di poco inferiore ai 3200 Kmq.
Sull’intero corso d’acqua hanno funzionato, per consistenti periodi di tempo, le stazioni di misura idrometrografiche indicate nella tabella che segue, unitamente ad alcune delle loro principali caratteristiche:
Sull’intero corso d’acqua hanno funzionato, per consistenti periodi di tempo, le stazioni di misura idrometrografiche indicate nella tabella che segue, unitamente ad alcune delle loro principali caratteristiche:
|
Allo stato, considerato il cospicuo numero di osservazioni disponibile, è possibile effettuare, per alcune delle sezioni di misura sopra indicate, uno studio di tipo statistico per valutare il legame funzionale tra la frequenza dei valori massimi delle portate al colmo annualmente osservati ed i valori stessi.
In particolare è possibile valutare la probabilità del verificarsi di una piena di determinata entità in termini di "tempo di ritorno" da intendersi, in senso statistico, come intervallo medio di tempo intercorrente tra due piene di quel valore.
Rivestono particolare interesse, per la tecnica, i tempi di ritorno di 100 e 1000 anni cui corrispondono, generalmente, le piene cui fare riferimento per manufatti di notevole importanza (100 anni) e le piene massime ritenute possibili (1000 anni).
I risultati dei calcoli effettuati sono riportati nella tabella che segue:
In particolare è possibile valutare la probabilità del verificarsi di una piena di determinata entità in termini di "tempo di ritorno" da intendersi, in senso statistico, come intervallo medio di tempo intercorrente tra due piene di quel valore.
Rivestono particolare interesse, per la tecnica, i tempi di ritorno di 100 e 1000 anni cui corrispondono, generalmente, le piene cui fare riferimento per manufatti di notevole importanza (100 anni) e le piene massime ritenute possibili (1000 anni).
I risultati dei calcoli effettuati sono riportati nella tabella che segue:
Corso d'acqua
|
Stazione
| Q100 anni (mc/s) | Q1000 anni (mc/s) |
| ATERNO | |||
| Molina |
72
|
86
| |
| TASSO | |||
| Scanno |
14
|
21
| |
| SAGITTARIO | |||
| Villalago |
4
|
10
| |
| Caponale |
79
|
133
| |
| ATERNO-SAGITTARIO | |||
| Alloggiamento |
92
|
108
| |
| TIRINO | |||
| Madonnina |
24
|
37
| |
| PESCARA | |||
| Maraone |
120
|
135
| |
| Santa Teresa |
1171
|
2056
|
Nella tabella che segue, infine, sono indicati, per le stesse stazioni di misura, due dati interessanti, e precisamente:
- il confronto tra la portata media di tutto il periodo di osservazione e la portata media del periodo di osservazione successivo al 1970;
- il rapporto tra la portata con tempo di ritorno di 100 anni e la portata media annua.
- il confronto tra la portata media di tutto il periodo di osservazione e la portata media del periodo di osservazione successivo al 1970;
- il rapporto tra la portata con tempo di ritorno di 100 anni e la portata media annua.
Corso d'acqua
|
Stazione
|
Portata media per tutto il periodo (mc/s)
|
Portata media per il periodo successivo al 1970 (m/s)
| Q100 anni(mc/s) | Qmedio Q100 anni(mc/s) |
| ATERNO | |||||
| Molina |
5,10
|
3,26
|
72
|
14,1
| |
| TASSO | |||||
| Scanno |
0,70
|
0,41
|
14
|
20,0
| |
| SAGITTARIO | |||||
| Villalago |
1,32
|
1,04
|
4
|
3,0
| |
| Caponale |
6,87
|
6,40
|
79
|
11,5
| |
| ATERNO-SAGITTARIO | |||||
| Alloggiamento |
15,27
|
15,42
|
92
|
6,0
| |
| TIRINO | |||||
| Madonnina |
7,24
|
7,08
|
24
|
3.3
| |
| PESCARA | |||||
| Maraone |
27,01
|
23,73
|
120
|
4,4
| |
| Santa Teresa |
50,00
|
42,49
|
1171
|
23,4
|
Dall’analisi delle tabelle si possono trarre alcune interessanti conclusioni sul regime dei deflussi del Fiume Pescara, ed in particolare:
Le portate dell’Aterno e del Sagittario, sia come valori medi annui che come valori massimi al colmo, sono sensibilmente inferiori, anche tenuto conto della minore estensione del bacino imbrifero, alle corrispondenti portate del Pescara misurate a Santa Teresa di Spoltore.
Il regime di tali portate è decisamente più costante, atteso che il rapporto tra portata massima al colmo e portata media è decisamente meno elevato del corrispondente rapporto valutato a S. Teresa (Molina: Q100/Qmed = 14.1; Capocanale: Q100/Qmed= 11.5; S. Teresa: Q100/Qmed = 23.4).
I regimi delle portate del Sagittario a Villalago (Q100/Qmed = 3.0) e del Tirino (Q100/Qmed = 3.3) sono ancora più costanti, segno certo di una alimentazione prevalente da sorgenti più che da deflussi superficiali.
Le portate di massima piena del Pescara alla foce dipendono essenzialmente dalle precipitazioni che avvengono a valle della gola di Popoli, ed in particolare, dalla zona di Caramanico e S. Eufemia, ove tali precipitazioni (veditavola 2) sono più intense.
Le portate in corrispondenza di quasi tutte le sezioni di misura, ad eccezione dell’Aterno-Sagittario ad Alloggiamento Idraulico, sono diminuite nel periodo di osservazione successivo al 1970, e ciò sia per la diminuzione degli afflussi, sia, probabilmente, per i maggiori prelievi di acqua per usi diversi.
La diminuzione di portata del Pescara alla sezione di misura di S. Teresa di Spoltore è particolarmente evidente (da 50.0 a 42,5 mc/s) con un decremento di circa il 15% che non sembra stabilizzarsi negli ultimi anni di osservazione.
Resta, da quanto sopra, confermato l’assunto iniziale circa la maggiore permeabilità dei sottobacini a monte della gola di Popoli per effetto della quale le precipitazioni, anche di notevole intensità, confluiscono in misura percentuale rilevante nella falda sotterranea più che nell’alveo dei corsi d’acqua.
Dalla falda, quindi, riemergono in corrispondenza di sorgenti e polle, delle quali le più notevoli sono quella di Capo Pescara, che confluiscono nel Pescara, e quelle di Capo d’Acqua che danno origine al Fiume Tirino.
Il deflusso dalle risorgive, inoltre, avviene in tempi differiti rispetto alle precipitazioni, tanto da essere pressoché costante nel tempo ed indipendente dalle precipitazioni meteoriche; ciò testimonia anche della notevole capacità dell’acquifero profondo, in grado di compensare in larga misura le fluttuazioni stagionali delle precipitazioni.
Il regime pluviometrico
Le portate di massima piena del Pescara alla foce dipendono essenzialmente dalle precipitazioni che avvengono a valle della gola di Popoli, ed in particolare, dalla zona di Caramanico e S. Eufemia, ove tali precipitazioni (vedi tavola 2) sono più intense.
tavola 2 : le isoiete sono le linee che congiungono i punti ad uguale quantità di acqua piovuta in un anno (in mm.)
Nella corografia (tavola 1) le ubicazioni delle stazioni sono referenziate con diversa simbologia a seconda dello strumento e diversa colorazione a seconda della quota.
Nella corografia schematica (tavola 2) è evidenziato il regime pluviometrico dell’intero bacino per mezzo delle isoiete relative alle precipitazioni medie annue misurate in corrispondenza delle stazioni elencate.
Dall’andamento schematico delle isoiete, tracciate con metodo automatico, appare evidente come i sottobacini dell’Aterno e del Sagittario, per quanto sopra detto, siano soggetti a minori precipitazioni, nonostante la loro maggior quota media.
Appare, inoltre, evidente come le precipitazioni di maggiore entità si verifichino in corrispondenza dell’alto bacino del fiume Orta, immediatamente a ridosso del massiccio della Maiella, esposto ai flussi d’aria provenienti da nord.
Nei grafici che seguono sono indicate, per l’intero bacino e per i sottobacini dell’Aterno, del Sagittario e del Pescara, come definiti, le correlazioni esistenti tra precipitazione media annua e la quota del sito di misura, sempre con riferimento alle stazioni pluviometriche riportate nella tabella (tavola 1).
Nella corografia schematica (tavola 2) è evidenziato il regime pluviometrico dell’intero bacino per mezzo delle isoiete relative alle precipitazioni medie annue misurate in corrispondenza delle stazioni elencate.
Dall’andamento schematico delle isoiete, tracciate con metodo automatico, appare evidente come i sottobacini dell’Aterno e del Sagittario, per quanto sopra detto, siano soggetti a minori precipitazioni, nonostante la loro maggior quota media.
Appare, inoltre, evidente come le precipitazioni di maggiore entità si verifichino in corrispondenza dell’alto bacino del fiume Orta, immediatamente a ridosso del massiccio della Maiella, esposto ai flussi d’aria provenienti da nord.
Nei grafici che seguono sono indicate, per l’intero bacino e per i sottobacini dell’Aterno, del Sagittario e del Pescara, come definiti, le correlazioni esistenti tra precipitazione media annua e la quota del sito di misura, sempre con riferimento alle stazioni pluviometriche riportate nella tabella (tavola 1).
 |
Nella scala verticale a sinistra sono raffigurate le precipitazioni in mm.
Nella scala orizzontale sono raffigurate le altezze sul livello del mare.
|
Dai grafici e dalle equazioni e dai coefficienti di correlazione si deduce che:
- limitatamente ai bacini dell’Aterno e del Pescara esiste una correlazione, anche se modesta, tra quota d’impianto della stazione pluviometrica e precipitazione media annua;
- per il bacino del Sagittario la correlazione tra quota ed altezza di precipitazione annua è pressoché inesistente, probabilmente anche a causa del minor numero di stazioni alle quali si è potuta estendere l’indagine;
- nell’intero bacino del Pescara la precipitazione media annua cresce di circa 20 mm per ogni 100 metri di quota;
- il valore della precipitazione media annua corrispondente alla quota 0 è pari a circa 570 mm nei bacino dell’Aterno, e cresce, nel bacino del solo Fiume Pescara, sino ad un valore di circa 810 mm.
- per il bacino del Sagittario la correlazione tra quota ed altezza di precipitazione annua è pressoché inesistente, probabilmente anche a causa del minor numero di stazioni alle quali si è potuta estendere l’indagine;
- nell’intero bacino del Pescara la precipitazione media annua cresce di circa 20 mm per ogni 100 metri di quota;
- il valore della precipitazione media annua corrispondente alla quota 0 è pari a circa 570 mm nei bacino dell’Aterno, e cresce, nel bacino del solo Fiume Pescara, sino ad un valore di circa 810 mm.
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||